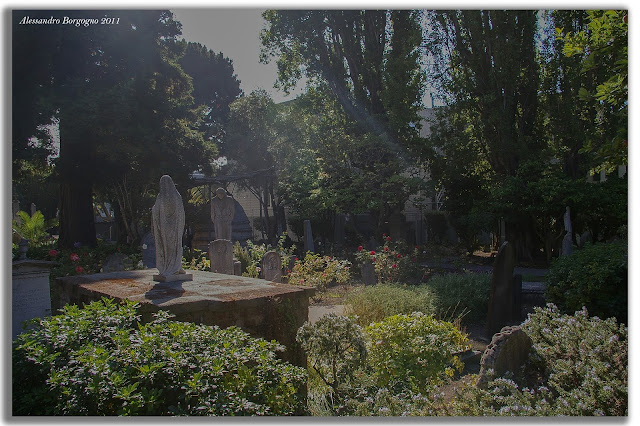di Alessandro Borgogno
C’è un cinema che è nato, è stato pensato e realizzato per essere visto su un grande schermo, in una sala buia, fermi al proprio posto e senza distrazioni.
È tutto il cinema nato e cresciuto prima del sonoro e poi proseguito fino all'avvento delle tecnologie che ne hanno permesso la visione anche con altri strumenti, in altri contesti e con altri ritmi (la televisione prima, poi le videocassette, i dvd, i blue-ray e ora qualunque supporto digitale online, in streaming, on demand, con visioni racchiuse in schermi sempre più piccoli, casalinghi, minimi e ridotti fino a quello di uno smartphone).
Quel cinema non siamo più abituati a viverlo, perché quando andiamo a vedere un film appena uscito in una sala, si tratta di una pellicola ormai realizzata con le tecnologie di oggi e pensata sapendo che la sua fruizione si moltiplicherà su cento altri supporti. A nessuno più viene in mente di fare una inquadratura come le panoramiche di Sergio Leone con un personaggio piccolissimo in un punto laterale della scena, perché su uno schermo non abbastanza grande si rischierebbe di non vederlo neanche.
 |
| Alfred Hitchcocks - The Birds |
Era quindi imperdibile l’occasione di vedere sul grande schermo, ridistribuito eccezionalmente a seguito del restauro audio e video delle copie originali (dal progetto “Il Cinema ritrovato” portato avanti dalla Cineteca di Bologna, visto a Roma al “Nuovo Sacher” di Nanni Moretti il 21 Gennaio 2019) il suo più colossale incubo visionario, raggiungimento delle più alte vette del suo cinema sia per il livello di suspense, sia per la spettacolarità delle scene, sia per la penetrazione psicologica dei personaggi.
Parliamo ovviamente de “Gli Uccelli”, pazzesca impresa creativa e produttiva datata 1963, vero testamento artistico di uno dei più audaci e consapevoli geni della storia della narrazione cinematografica.
Difficile parlare ancora di un film sul quale è già stato detto quasi tutto e del quale anche qui si è già parlato, ma la visione in sala, inchiodati alla sedia con lo schermo enorme di fronte e i suoni che circondano lo spettatore fino allo sfinimento, lo rende un film nuovo di zecca, come una prima visione, anche a chi lo conosce a memoria per averlo visto e perfino studiato decine di volte (ebbene sì, io sono uno di quelli).
 |
| Tippi Hedren |
E poi l’audio originale (con sottotitoli, ma per chi conosce il film a memoria perfino inutili) ci fa finalmente ascoltare la sua voce. Limpida, intensa e armonica. E del resto tutti gli attori, per tutto il film, parlano un inglese pulito e comprensibilissimo. In barba alla verosimiglianza, anche l’ubriacone del bar si esprime in modo corretto e scandisce le parole perfino con una sua eleganza. Eppure nulla suona falso. Altri tempi, ma per nulla invecchiati.
La lingua originale ci permette inoltre di cogliere anche molte finezze che inevitabilmente nel doppiaggio si perdono, una delle più famose (ne discutono anche Hitch e Truffaut nella famosa intervista) riguarda gli uccellini in gabbia che attraversano tutta la storia, continuamente richiamati dai protagonisti col loro nome che in italiano sarebbe “Inseparabili” e tradotto (anche giustamente visto che il nome italiano avrebbe poco senso) semplicemente in “pappagallini”, ma che in inglese si chiamano molto più significativamente “Love birds”. E questo nome che diventa quasi un suono, “love birds”, risuona per tutto il film a fare da contrappunto anche sonoro sia utilizzato come doppio senso (a simboleggiare l’amore nascente o mancato fra i diversi personaggi) che come contrasto quasi sarcastico (tutti parlano continuamente di “uccelli d’amore” mentre tutto intorno altri uccelli scatenano tutto il loro odio). E tralasciamo anche le allusioni sessuali che sarebbero fin troppo facili.
Poi, già che si parla del suono, la colonna sonora. La visione al cinema amplifica e rende strabiliante una delle caratteristiche spesso dimenticate ma più clamorose del film: è totalmente privo di musica. Quasi portandoci a un realismo fuori dai canoni Hollywoodiani (non di oggi, ma di sempre) non c’è un solo momento del film che sia sottolineato da una qualsiasi melodia fuori campo. I suoni sono solo quelli delle scene che si susseguono, l’ambiente, le voci dei protagonisti, i rumori della cittadina e della natura, naturalmente le grida degli uccelli. Ma, come si sa, ciò non significa che il film non abbia una partitura, anzi ce l’ha proprio, dal primo all'ultimo secondo. Non a caso Bernard Hermann, storico compositore dei film del maestro, lavora anche qui come supervisore di altri due musicisti, Matthew Ross e Oskar Sala, perché tutta la colonna sonora e tutti i suoni sono progettati e applicati al film esattamente come le melodie di una sinfonia. Anche i silenzi (che infatti non sono mai semplice assenza di suono ma ronzii, deboli rumori, versi lontani) seguono uno spartito, hanno i loro momenti di adagio, di svelto, i loro crescendo, le loro pause. Un lavoro parallelo immenso e totalmente originale, che in sala si coglie in tutta la sua efficacia espressiva e narrativa.
 |
| The Birds storyboard |
Per gli stessi motivi anche momenti molto famosi e dei quali (quantomeno gli “esperti” o i fissati) conoscono ogni fotogramma, si rivelano amplificati e finalmente in tutta la loro genialità ed efficacia. Giusto per citarne uno, la scena in cui la madre di Mitch (una superba Jessica Tandy) arriva col pick-up alla fattoria di un suo vicino. Entra, vede le tazze rotte in cucina (associazione visiva diretta e folgorante con poche scene prima quando Hitch ci aveva mostrato, sempre mentre i dialoghi dicevano altro, il suo progressivo crollo psicologico nel raccogliere proprio i cocci delle tazzine nel salotto dopo l’invasione di uno stormo di passeri), scopre il proprietario ucciso in modo orribile dagli uccelli, fugge di corsa (tentando di urlare ma senza che le esca alcun suono dalla bocca, altra soluzione geniale e raggelante) risale sul furgoncino e corre via.
Si sa, perché lo stesso Hitch lo racconta, che per questa scena fece bagnare la strada per l’arrivo del furgoncino in modo che arrivasse senza sollevare polvere. Questo gli ha permesso di riprendere la scena della fuga con la stessa inquadratura (da lontano) ma facendo sì che invece al momento di lasciare la fattoria il pick-up sollevasse grandi turbini polverosi dietro di sé. Con un transfert semplice, diretto e non equivocabile, anziché farci vedere un personaggio che arriva tranquillo e poi fugge in preda al panico, ci fa vedere un camioncino che arriva tranquillo e poi fugge agitato. Conoscevo questa scena a memoria (potrei disegnarla), ma vista sul grande schermo è davvero magnifica.
Nulla, ma proprio nulla, in più di due ore di film, è lasciato al caso, e ogni riferimento concettuale, visivo e anche simbolico nella visione in sala (che, non ci stanchiamo mai di ripeterlo, riporta il film nelle condizioni per cui era stato concepito e realizzato) risalta in modo inequivocabile: il tema dell’abbandono (Melanie abbandonata da piccola dalla madre, la madre di Mitch che ha il terrore di essere abbandonata dal figlio, la maestra a sua volta abbandonata da Mitch ma che non riesce a starne lontano); il percorso cristologico della protagonista da ricca sofisticata e viziata (“torna nella tua gabbia dorata, Melanie Daniels!” dice Mitch nella prima scena) al totale ribaltamento della sua condizione (lei finisce davvero in gabbia, nella cabina telefonica, circondata da uccelli che la attaccano) fino al martirio della scena finale; il celeberrimo tema della Visione (gli uccelli cavano gli occhi alle vittime, ogni scena si chiude con un personaggio che guarda “fuori”) del quale si coglie un dettaglio ancora più sottile grazie alla lingua originale, giacché i protagonisti dicono continuamente, e allusivamente, “capisco…”, che però in inglese è “I see”, e in questo modo con uno dei tanti doppi sensi che amava tanto il maestro londinese non fanno che ripetere “Io vedo”; l’incomunicabilità (i personaggi fra loro faticano a comprendersi per gran parte del film trovando forse i primi punti di contatto proprio al progredire dell’apocalisse, e in una delle tante scene madri gli avventori del ristorante non riescono ad avvisare l’uomo nel parcheggio del pericolo che sta correndo accendendosi un sigaro mentre scorre benzina sul piazzale); la frantumazione (dei rapporti, dell’equilibrio psicofisico delle persone, dei vetri, delle tazzine, perfino dei titoli di testa che si spezzettano al passaggio degli uccelli); e così via, si potrebbe proseguire per ore, ma tanto per non tralasciare uno dei temi di schiacciante attualità del film, il terribile momento in cui il terrore che attanaglia gli abitanti fuoriesce alla ricerca di un nemico e alfine identificandolo facilmente nello “straniero”, quando al ristorante la signora con i figlioletti terrorizzati esplode in una scena isterica accusando Melanie di tutto il male che li sta colpendo: “è colpa tua! È iniziato tutto da quando sei venuta tu! Tu non sei una di noi! Tu sei il male!”. E non c’è bisogno di dire altro.
 |
| Potter School - Bodega |
Scena suntuosa che al cinema esplode in tutta la sua furia sinfonica: Overture, con Melanie che arriva alla scuola e poi si siede ad aspettare fuori vicino ai giochi dei bimbi; Adagio, con i primi piani di Melanie che fuma (alla faccia dell’attuale politically correct, come si potrebbe immaginare questa scena senza la sigaretta di Tippi?), la cantilena dei bambini che arriva attutita dalla classe, i corvi che iniziano a radunarsi dietro di lei; Crescendo, con la suspense tipica del maestro che si esprime con la progressione irregolare di un corvo, tre corvi, cinque corvi, dieci corvi e poi… ; Colpo di piatti (citazione per citazione) improvvisamente cento corvi!; Sospensione (suspense); Melanie entra a scuola, avvisa la maestra, la classe si prepara a uscire per scappare, i corvi sono fermi in silenzio; Presto, si sentono i passi dei bambini che iniziano a correre, i corvi si alzano improvvisamente tutti insieme e quel punto la sinfonia esplode con tutti gli strumenti in campo: la corsa dei bambini, l’attacco dei corvi, le urla, le grida degli uccelli, la violenza, il dettaglio degli occhiali rotti di una bimba sull'asfalto (dettaglio Ėjzenštejniano, e nuovo richiamo al tema della “visione”).
Un incubo orchestrato alla perfezione.
Non si finirebbe più ma almeno un’altra scena merita una menzione speciale, perché vissuta (non vista, vissuta) in sala raggiunge dei livelli quasi insostenibili.
L’ultimo attacco alla casa, mentre i protagonisti sono tutti dentro (di nuovo in gabbia) barricati per resistere. L’attacco è totalmente sonoro, decisamente ispirato agli attacchi aerei della seconda guerra mondiale, ma la messa in scena e i suoni al cinema sono un attacco deliberato e prolungato ai sensi (e ai nervi) dello spettatore. Ma non bastasse questo, la camera inquadra le vittime con una precisione entomologica mentre si muovono alla ricerca di un riparo da una minaccia che non si vede. Per fare questo Hitch li riprende sempre con molto spazio davanti a loro (e sullo schermo lo spazio vuoto diventa enorme), per non farci mai dimenticare che stanno cercando di nascondersi da qualcosa che non c’è, e in questo modo ci mostra come non abbiano alcuna possibilità di mettersi in salvo. Non ci si nasconde da un suono, in qualunque angolo si tenti di accucciarsi. I loro movimenti sono senza senso, e il regista ce lo mostra senza alcuna pietà. Quella scena, inchiodati sulle poltrone del cinema (eguagliata in identificazione e disagio dello spettatore solo dalla scena madre de “la finestra sul cortile”) raggiunge livelli di partecipazione allucinanti. Si trema anche se la si conosce a memoria, salgono i brividi anche se sai già come andrà a finire, vorresti scappare ma non puoi, esattamente come loro.
 |
| La baia di Bodega Bay |
Fedele complice dei deliri visivi del genio londinese, lo ha seguito e assecondato con la sua maestria fin dal 1951 (con “L’altro uomo – Strangers on a train”) firmando un elenco di titoli che fa impressione: “Il delitto perfetto” (1954), “La finestra sul cortile” (1954), “L’uomo che sapeva troppo” (1956), “Il ladro” (1956), “La donna che visse due volte” (1958), “Intrigo internazionale” (1959), “Gli uccelli” (1963), “Marnie” (1964). Per quei film, e per le esigenze di un regista come Hitchcock che ad ogni girato inventava cose nuove, occorreva continuamente trovare delle soluzioni per illuminare scene in teatro di posa che poi venivano montate con sfondi o altri trucchi per diventare scene all'aperto.
Virtuoso di posizionamento e diffusione delle luci, ricreare in modo artificiale la luce naturale del giorno era uno dei suoi “passatempi” preferiti. Se si guarda con occhio attento molte di quelle scene, ci si accorge (e non sempre) di quante siano le situazioni in cui si passa da una luce artificiale ad una naturale senza che quasi se ne abbia percezione o in quanti casi nella stessa immagine siano combinate insieme parti di diverse inquadrature riprese in condizioni completamente differenti (solo “Intrigo internazionale” è un luna park di piccoli trucchi ed effetti che per la gran parte sfuggono all'occhio proprio grazie alla capacità di Burks di uniformare la luce).
Ma naturalmente è qui, nella follia de “Gli uccelli”, che raggiunge la sua vetta, e la visione in technicolor sullo schermo ce ne dà tutta la grandezza. “Gli uccelli” è un film pazzesco realizzato in un momento storico in cui era sostanzialmente impossibile realizzarlo. Un’impresa sbalorditiva sotto tutti i punti di vista (espressivo, tecnico, narrativo) che solo un regista come Hitchcock poteva intraprendere e solo un autore fotografico di pari genio e competenza poteva seguire assecondandolo e trovando ogni volta le soluzioni più adatte. Ogni trucco, ogni trovata fotografica e cinematografica utilizzata per quel film è stata inventata in quella occasione, per la prima volta (perfino l’utilizzo di cartoni animati sovrapposti a riprese reali, grazie alla consulenza di un altro grande, Ub Iwerks, genio dell’animazione proveniente direttamente dagli studi Disney). Elencarle tutte sarebbe impossibile, anche se non si può non citare la ripresa dall’alto di Bodega Bay mentre divampa l’incendio con i gabbiani che compaiono riempiendo piano piano lo schermo. È più di una ripresa “a volo d’uccello”. È, per la prima volta, “il punto di vista degli uccelli”.
 |
| La scena finale |
Lo so, siamo di parte ed esageriamo, volontariamente e coscientemente, perché siamo convinti che sia giusto farlo: la visione de “Gli Uccelli” di Alfred Hitchcock al cinema, sul grande schermo nella sala buia, è qualcosa di più della semplice visione di un grande film. È un’esperienza fuori dal comune.
Follow my blog with Bloglovin